
Il sindaco dell’atomo
Parafrasando Caruso Pascoski (di padre polacco) invece di pensare a Giulia, il primo cittadino spezzino parrebbe il sindaco dell’atomo. Così ama il nucleare, non c’è niente da fare, è più forte di lui. Una battuta? Forse. Sta di fatto che parole (tante), atti e opere di Pierluigi Peracchini appaio lievemente in controtendenza alla sovranità popolare. Un paradosso, nel tempo in cui, una volta eletti, i sindaci appaiono come capi indiscussi voluti dal popolo.
 Questa riflessione rimbalza tra passato e presente, con un fosco futuro all’orizzonte. Nel 1987, 20 milioni di italiani dissero no al nucleare. 14 anni dopo toccò a 25 milioni ribadirlo. Nella tornata referendaria del 2011 il contributo degli aventi diritto spezzini fu di 40.419 voti contro l’atomo. 4000 in più di chi ha votato alle comunali del 2022, dove Peracchini raccolse 19.379 voti che gli consentirono (53,58%) di essere rieletto. Ma nonostante il popolo abbia espresso, democraticamente, la propria opinione sul nucleare, le sirene ritornano con cadenze regolari. Ed il sindaco spezzino, parrebbe tra i più solerti sostenitori.
Questa riflessione rimbalza tra passato e presente, con un fosco futuro all’orizzonte. Nel 1987, 20 milioni di italiani dissero no al nucleare. 14 anni dopo toccò a 25 milioni ribadirlo. Nella tornata referendaria del 2011 il contributo degli aventi diritto spezzini fu di 40.419 voti contro l’atomo. 4000 in più di chi ha votato alle comunali del 2022, dove Peracchini raccolse 19.379 voti che gli consentirono (53,58%) di essere rieletto. Ma nonostante il popolo abbia espresso, democraticamente, la propria opinione sul nucleare, le sirene ritornano con cadenze regolari. Ed il sindaco spezzino, parrebbe tra i più solerti sostenitori.
Tra un taglio di nastro e l’altro, tra le attività del sindaco “sprugolino” c’è un convegno. Si terrà il 17 febbraio 2025, nell’auditorium dell’Autorità portuale spezzina. L’energia nucleare che ci attende. L’happening è organizzato dalla Società Dante Alighieri, con il patrocinio del comune della Spezia e della locale Confindustria. Oltre alla fascia tricolore, nientemeno che Giacomo Raul Giampedrone, assessore all’Ambiente della regione Liguria ed uno stuolo di esperti, naturalmente tutti pro atomo.
La Spezia potrebbe diventare una capitale nel settore della ricerca sulla fusione nucleare, ospitando un centro di ricerca dedicato all’esperimento Divertor tokamak test sulla fusione nucleare nelle aree ex Enel. L’opportunità si inquadra nel modello di città che abbiamo in mente che prevede tra gli altri il potenziamento di settori come le alte tecnologie, università, turismo e nautica.
Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia
(28 Gennaio 2018)
Molti anni fa scrissi un’approfondimento sul tema, che oggi vale la pena rivedere ed aggiornare. Al netto di sondaggi d’opinione e di golpe antireferendari, pare che l’unica proposta di vendita sia sempre quella. L’energia nucleare. Ci siamo dimenticati che il 26 aprile 1986, durante l’esecuzione di un test di sicurezza, esplose il reattore 4 della centrale nucleare di Černobyl’. Dall’Ucraina sovietica una nube radioattiva ricadde su una vasta area, contaminando, in quantità via via minori, mezzo globo.
Quell’area, oggi teatro di guerra, fu tristemente nota come Quarta Zona. Nel raggio di 30 chilometri, le autorità evacuarono circa 340.000 persone. Il rapporto redatto dalle agenzie ONU, dall’OMS all’IAEA, ufficializzò 65 morti accertati. Il Chernobyl Forum, nella sua seconda edizione, riporta 4.000 i decessi per tumori e leucemie, riconducibili conseguenze radioattive. Un bilancio apocalittico, peraltro contestato da rapporti ancora più catastrofici. TORCH valuta 60.000 decessi, Greenpeace 6.000.000 decessi globali. Quello che fu il più grave incidente nucleare della storia (escluso i bombardamenti del Giappone), non è che il primo di una serie che iniziò a produrre crepe nell’opinione pubblica. Ciò nonostante il mito dell’energia atomica ha sempre trovato proselitismo.
Se è vero che il tempo è galantuomo, in questo caso “la notte atomica ci ha rimboccato le palpebre”. Chirurgiche operazioni mediatiche riportano il mito a galla. Da ex-ambientalisti d’assalto divenuti coscienziosi e pragmatici realisti a governi compiacenti con classi prenditoriali sempre più vampiresche, la lista è lunga. L’ennesimo inganno globale, gemello della crescita infinita e parente della finanza creativa, cerca costantemente di convincere l’opinione pubblica. Dati di pochi e selezionati istituti, analisi che escludono le statistiche più impietose. Con due pesi e due misure. Modelli teorici incoraggianti per l’atomo, statistiche restrittive per altre tecnologie. Lo scopo è di “impedire che la paura vinca sulla ragione”. Intanto il sonno della medesima propone altri reattori.
Ma la storia (nucleare) si ripete per la seconda volta: la prima in tragedia, la seconda anche. L’11 marzo 2011, le conseguenze di un terremoto mettono in crisi tre centrali nucleari giapponesi, sulla riva del Pacifico: Onagawa, Fukushima Daini e Fukushima Daiichi. In quest’ultima la situazione precipita per la perdita di fluido refrigerante ed esplodono tre reattori. Il reattore 3 contenente MOX, un combustibile particolarmente pericoloso, prodotto riciclando plutonio e scarti dei processi di arricchimento dell’uranio, proveniente dall’impianto di stoccaggio a La Hague e consegnato da Areva in tre mandate: marzo 1999, 2010, 2011. Dopo l’incidente le analisi sui campioni di suolo, in un raggio di 30 chilometri dalla centrale, presentano valori di cesio fino a 2,19 Mbq/m3. Nella zona di evacuazione di Černobyl’, tutt’ora inaccessibile, si registravano contaminazioni per 0,55 Mbq/m3.
La radioattività nei bunker dei reattori nipponici arriva oggi ancora a 270 Sv/h. In Italia, il limite di “dose” per un lavoratore è di 20 mSv/anno. Secondo i dati forniti da TEPCo, il gestore dell’impianto giapponese, a 20 chilometri dalla costa, un chilo di sedimenti del fondale registra 90 MBq di cesio-134 e 52 MBq di iodio-131,. Dall’incidente, oltre 1,3 milioni di tonnellate di acque reflue nucleari sono state raccolte, trattate e immagazzinate in un parco serbatoi dell’impianto. Oggi quel deposito sta per esaurirsi, dice il governo giapponese, non lasciando altra scelta se non quella di iniziare a dispensare le acque reflue nel Pacifico. Fukushima raggiunse il 7° livello INES, come Černobyl’, ma con tre reattori fuori controllo, 185.000 persone evacuate. Tutto il Giappone fu messo in ginocchio: 66 reattori operativi (su 136) e la produzione elettrica fu dimezzata.
Ricapitolando. Fallì la disciplina sovietica e fallì la precisione nipponica. Ma sul nucleare “convinceremo gli italiani“, diceva quel tale. Come se nel bel paese ci fossero i presupposti per dar le piste a russi e giapponesi. Ciò nonostante, la litanie è sempre pronta. Badate che il meccanismo è semplicissimo. Problemi complessi? Risposte semplici. Peccato che semplificare il nucleare, oltre che rischioso, sia un’operazione che implica una dose generosa di disonestà intellettuale.
Il nucleare non ci rende indipendenti da fonti fossili. Banalmente perché si alimenta di una di esse. L’uranio è un combustibile che, agli attuali ritmi di consumo, si esaurirà nei prossimi decenni. Ogni anno i 440 reattori in funzione nel mondo consumano circa 69.000 tonnellate di uranio. La prospettiva, al 2030, è quella di altri 545 reattori (61 in costruzione, 158 pianificati e 326 proposti). Il doppio dell’uranio attualmente in consumo, significa depredare ulteriormente i paesi in via di (perenne) sviluppo, come il Niger, per esempio. Areva ha estratto uranio dalle miniere africane per 40 anni, utilizzando 270 miliardi di litri d’acqua, con l’impoverimento e la contaminazione delle falde acquifere e, per le strade della città mineraria di Akokan, la radioattività è circa 500 volte superiore alla media continentale, con tassi di mortalità doppi rispetto al resto del paese.
Il nucleare non ci affranca dalla dipendenza dal petrolio, poiché produce sostanzialmente energia elettrica, fetta importante della torta energetica, non certo l’unica. La Francia, terra promessa dell’atomo, con i suoi 58 reattori produce il 75,2% dell’energia elettrica ma consuma 1,705,568 barili al giorno, 401.7 pro-capite all’anno. Il dato italiano è di 1,236,628 barili al giorno, 313.5 pro-capite all’anno. Inoltre la Francia vive un vero paradosso. I reattori non si possono regolare al variare della domanda come altri sistemi di generazione, quindi il sistema elettrico è molto rigido e non a caso nessun governo francese si è azzardato a privatizzare EDF, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia transalpina. Così le centrali nucleari oltralpe producono un surplus nelle ore notturne, vendendolo a prezzi molto bassi, ma in situazioni di picco si trovano a comprare elettricità dall’estero, quando i dati sulla produzione lorda di energia elettrica danno il quadro della situazione.
Il nucleare non contribuisce a ridurre il global warning. Dall’estrazione alla lavorazione per ottenere un chilogrammo di uranio occorre una tonnellata di minerale, producendo enormi quantità di CO2. Tralasciamo che la costruzione delle centrali stesse richiede enormi quantità di cemento e acciaio? Trascuriamo le fasi di stoccaggio delle scorie e di decommissioning, ovvero di dismissione delle centrali? La somma fa il totale e produrre energia elettrica con il nucleare significa diminuire le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto ad una centrale a gas, ma nel computo complessivo pogge e buche fanno pari. Una sintesi un po’ rude, me ne rendo conto, ma c’è chi fa della ricerca e lo dimostra, come gli scienziati Frank Barnaby e James Kemp, autori de “Secure Energy? Civil Nuclear Power, Security and Global Warming”.
Secondo il rapporto IEA “Key World Energy Statistics“, i reattori nel mondo coprono il 5% dell’energia globale (9,6% nei paesi OCSE), quindi per avere un significativo abbattimento di gas serra, il nucleare dovrebbe coprire almeno il 20% del fabbisogno energetico mondiale, risultato raggiungibile solo con l’impressionante traguardo di 35 nuove centrali all’anno per i prossimi 60 anni. In ogni caso, qualunque valutazione che non tenga conto dell’intero ciclo di vita di un impianto nucleare, differendo oneri di stoccaggio e decommissioning, non è realistico.
Il nucleare non riduce il caro-bollette. Le centrali nucleari sono un affare solo con ingenti sovvenzioni pubbliche. Il costo di costruzione del reattore EPR che Areva sta sostenendo ad Olkiluoto (Finlandia), è schizzato da 3,3 a 5,5 miliardi di euro. La costruzione dei nuovi reattori aumenterà diffusamente per costi e tempi e, nell’ipotesi di un incremento del 20% delle spese e di ritardi medi di due anni. Indovinate chi pagherà i costi? Un indizio, la bolletta.
A partire dagli enormi costi di costruzione, il prezzo dell’energia dovrebbe essere almeno di 70 €/MW per giustificare gli investimenti. L’elettricità nucleare costa il 16% in più (72,8 €/MWh) di quella prodotta con il gas (61 €/MWh) e il 21% in più di quella prodotta con il carbone (57,5 €/Mwh). Negli USA, da tempo, l’energia elettrica solare costa meno di quella nucleare (16 ¢/kWh). Senza contare i costi “sociali”. Nel 2009 una tubatura sotterranea della centrale di Oyster Creek (New Jersey, USA) ha una perdita di trizio, contaminando la falda che approvvigiona un acquedotto. Soluzione? Far calare il sipario. Il gestore dell’impianto (Exelon Corporation) sostiene che i documenti sull’incidente sono riservati, Pensate che sia un caso isolato? Per nulla.
Il nucleare ha rischi per la salute. Esposizioni a radiazioni durante le gravidanze, seppur di piccole entità, sono alla base di aumenti di leucemie nei bambini sotto i 5 anni che vivono attorno alle centrali nucleari, dimostrazione che nel “normale” funzionamento avvengono perdite, ufficialmente mai menzionate. Negli ultimi 40 anni, intorno a 27 impianti nucleari tedeschi, si sono verificati circa 20.000 aborti spontanei, un calo significativo di nascite femminili, ed un netto aumento di deformità e tumori infantili. Solo nel raggio di 5 chilometri dalla centrale nucleare di Krümmel è stato documentato un aumento del 56% dei casi di leucemia infantile, nel decennio 1984-1993.
Il nucleare è un ottimo affare per i privati. Chi si farebbe sfuggire profitti colossali a zero rischi imprenditoriali, in condizioni pressoché monopolistiche, aiutati per di più da sovvenzioni pubbliche? Una litania: socializzare le perdite, in questo caso anche umane, e privatizzare i ricavi. La TEPCo, la più grande compagnia elettrica del Giappone, non ha mai cambiato rotta nonostante le documentate criticità dei suoi impianti. Nel 2004 quattro operai morirono per una fuga radioattiva a Mihama. Nel 2006 accadde un incidente simile a Fukushima, nel 2007 a Kashiwazaki-Kariwa 1.135 litri d’acqua contaminata finiscono in mare e nel 2011, dopo il disastro di Fukushima, arriva la beffa: per pagare i risarcimenti, circa 600 milioni di dollari, l’azienda taglia i salari dei lavoratori del 20%. Velo pietoso invece, sulle chiusure sequenziali degli impianti esistenti. USA, Germania, sono solo alcuni esempi in questo senso.
Il nucleare produce scorie radiative. Tutti i materiali usati per il funzionamento delle centrali e contaminati dalle radiazioni. Su questa tema, si apre un parentesi decisamente non trascurabile. Nessun paese ha ancora trovato una soluzione sicura, anzi, aumentano i traffici illegali gestiti da ecomafie diretti nei paesi poveri ed una questione ambientale diventa eufemisticamente generazionale: la radiotossicità è tale per periodi che vanno dai 300 al milione di anni, a seconda degli elementi radioattivi. Ad oggi la maggior parte dei combustibili esausti vengono stoccati in depositi provvisori, in virtù della natura intrinsecamente dual-use del nucleare. Un tema che coinvolge le nostre vite.
19 marzo 2014. La nave da trasporto di combustibile nucleare Pacific Egret approdò a Charleston (Carolina del Sud), scaricando un carico top secret nella Naval Weapons Station del porto. La nave britannica era costruita appositamente per trasportare plutonio, uranio altamente arricchito (HEU) e combustibile nucleare a ossido misto (MOX). Precedentemente fu segnalata all’uscita dal Mediterraneo, presso lo Stretto di Gibilterra, circa due settimane prima (7 marzo), trasportando il delicato carico nucleare. Da dove proveniva? Dalla Spezia.
Il 18 febbraio, una colonna di camion militari attraversò lo stivale, scortati dalle forze dell’ordine, per trasportare 38 contenitori sistemati in tre container, in gran segreto, fino alla base della Marina militare della Spezia e disporre le operazioni di carico su una nave mercantile. La notte del 3 marzo, la nave Pacific Egret salpa dalla Spezia. Prima di allora, nessuno aveva avuto notizie dell’evento, che tuttavia non passò inosservato. Dopo venti giorni di silenzi e di misteri, l’allora presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, svela rotta e carico: circa 74 chilogrammi di uranio misto a plutonio. Il caso suscitò l’attenzione del Parlamento: una prima interrogazione desta il Governo: “sono state promosse tutte le iniziative utili affinché il trasporto venisse effettuato in regime di massima sicurezza”.
Quindi, in generale, gli arsenali nucleari sono funzionale all’ammortamento dei costi del nucleare civile. Dunque nasce prima l’uovo o la gallina? Molti dimenticano che il battesimo del nucleare furono le stragi di civili ad Hiroshima e Nagasaki. All’inizio del 2024, nove stati (Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Repubblica popolare democratica di Corea e Israele, possedevano complessivamente circa 12 121 armi nucleari. La prima applicazione tecnica della fusione termonucleare, nella seconda metà del XX secolo, fu la bomba H. Senza contare il combustibile per le unità a propulsione nucleare o l’utilizzo dell’uranio impoverito. Di questo “scarto” si contano oltre il milione di tonnellate disponibili, per proiettili anticarro, per esempio, i cui effetti sono lungamente elencati.
Si torna al locale, alla storia che è divenuta libro. Il Piano di emergenza nucleare delle aree militari alla Spezia, era un documento segreto risalente all’ottobre 1999 (aggiornamento del precedente, risalente al 1974). Il medesimo documento esiste in altri porti in cui è previsto, per esempio, l’ormeggio di unità a propulsione nucleare (La Spezia, La Maddalena, Augusta, Taranto, Livorno, Brindisi, Gaeta, Venezia, Cagliari, Napoli e Trieste). Causalmente venne a galla l’esistenza di un piano d’emergenza di cui la comunità, e le sue rappresentanze democratiche, non sapevano nulla.
Nel 2000 fu distrattamente inviato alle autorità civili, rivelando che i militari avevano predisposto misure di emergenza in caso di “massimo incidente possibile”. La Prefettura spezzina prese in mano la questione e convocò le istituzioni locali, per coinvolgerle nell’aggiornamento del piano per i civili, risultando il primo caso nazionale in cui gli enti locali fossero coinvolti nella redazione di un simile piano d’emergenza. Oggi quel piano è aggiornato? Lo saprà certamente il sindaco Peracchini, partecipe dell’iniziativa atomica.
Ma la risposta a tutte queste riflessioni è il nucleare pulito. Quello che attendiamo di nuova generazione. Magari tinto di blu, fondamentale per sostenere attività estremamente energivore come l’alimentazione dei server dell’intelligenza artificiale. La questione nucleare è ben più profonda. I processi fisici che stanno alla sua base sono immensamente lontani dal concetto biologico di vita, basti pensare all’enorme densità energetica delle trasformazioni che avvengono in un reattore, annichilenti di ogni equilibrio della biosfera che ci circonda perché incompatibili con ogni suo parametro, i cui danni sono irreparabili tra spazio e tempo, oltre i limiti della nostra stessa esistenza. In tutto questo si può prescindere dall’esito democratico e dalle decisioni che il popolo ha assunto direttamente? Forse per un sindaco dell’atomo si, allora aboliamo i referendum, e anche elezioni?
Il problema principale di questo modello sociale sta nel fatto che il potere economico coincida con il potere politico. L’unico antidoto per invertire il cattivo funzionamento della democrazia è costruire una società critica che non si limiti ad accettare le cose per quello che sembrano ma non sono. Una società che si faccia domande e dica di no ogni volta che è giusto dire no.
José de Sousa Saramago
Questo articolo apparve, nella sua versione originaria, per la prima volta su https://www.informazionesostenibile.info/, nel 2011.
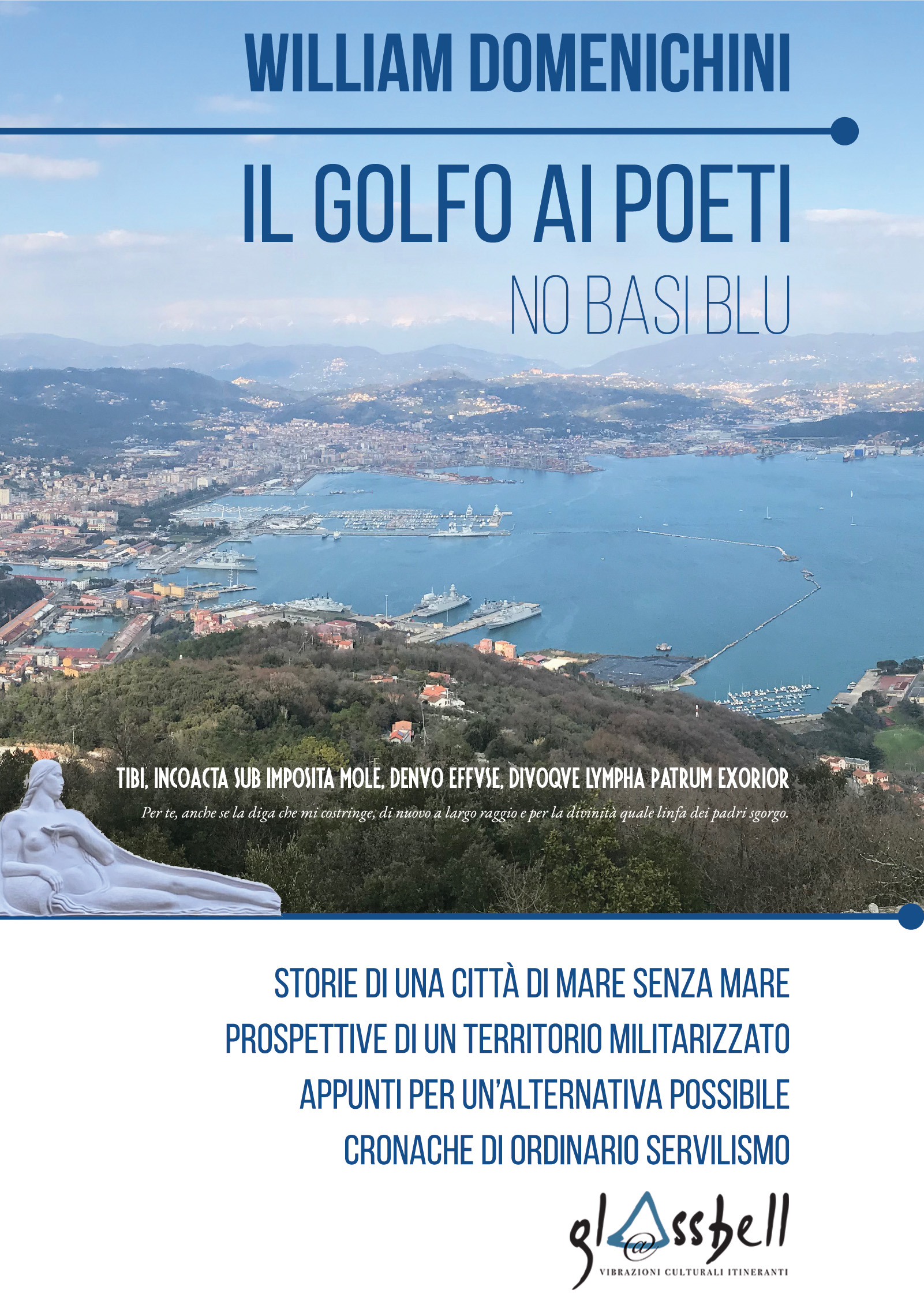
La necessità di avere una parte di energia nucleare per arrivare alla transizione Green è una delle poche cose che mi trova d’accordo con #Peracchini🤷.
Prenditi 10 minuti per leggere bene questa riflessione.